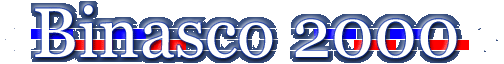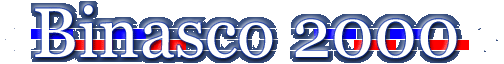|
|
 
| |  |  | Giorno della Memoria-Informazione Corretta
Commenta Vedi tutti gli argomenti
Il concetto di Zakhòr nella lingua ebraica
Di tutte le facoltà che l’uomo possiede, sicuramente la memoria è la più fragile, incerta, ingannevole. D’altra parte, l’essere umano si costruisce sulla memoria, senza la quale, come nel caso dei malati di Alzheimer, è come un albero senza radici. Proprio per questa sua labilità, la tradizione ebraica impone l’obbligo del ricordo, indicato con il termine Zakhòr. Questa parola ricorre per lo meno 169 volte nel testo biblico, in tutte le sue declinazioni e anche nel suo opposto, l’oblio. Ricordare e non dimenticare, di fatto, diventano sinonimi. La parola Zakhòr, “ricorda!”, è un imperativo di seconda persona singolare, che rimanda alla radice ZaKHaR (apparentata secondo i linguisti moderni a DaKHaR, “penetrare”, “pungere”, “infiggere”), che significa “maschio”, opposto a NeKeVà, cioè “foro”, “femmina”. ZaKHaR è quindi una cosa piantata nel cuore, che rimanda a SaKHaR, “chiusura”, simile al concetto di qualcosa che è custodito nel cuore, come se fosse una scatola ( La scrittura consonantica). «Tre volte all’anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio nel luogo che avrà scelto … e non si presenterà a mani vuote» (Deuteronomio, 16, 16). Commentando questo passo, che prescrive l’obbligo di tre pellegrinaggi all’anno al Santuario di Gerusalemme per portare offerte al Signore, alcuni Maestri invece di leggere “maschio” leggono “colui che ricorda” ( Bibbia, Torà, Talmùd). Significa che solo colui che risponde all’imperativo della memoria può accedere al sacro, avvicinarsi al Signore. Il rituale (pellegrinaggio e offerta al Santuario) ha significato solo se si combina con una visione etica della vita, fondata sul ricordo, che deve profondamente penetrare nella coscienza. Presentarsi davanti al Signore altro non è che guardare in sé, profondamente e sinceramente. E la memoria è la porta che consente questa presa di coscienza. Lo Zakhòr ebraico è un concetto religioso e riguarda quindi non solo l’uomo, ma anche Dio: è un imperativo che li lega in maniera indissolubile.E su questo imperativo si fonda la sopravvivenza del popolo ebraico e della sua identità, nonostante gli esili, le persecuzioni, i tentativi di sterminio, l’assimilazione. Di fatto per la tradizione ebraica la storia coincide con la memoria e, come si vedrà più avanti, è legata alla rivelazione divina, non sentita come fattore “mitico”, ma come presenza effettiva nella vicenda umana. La storiografia, come strumento principale di registrazione degli avvenimenti, qui non c’entra. Il senso della storia e il suo rapp orto con la memoria In genere, quando parliamo di storia pensiamo alla storiografia, intesa come scienza che, attraverso la ricerca di documenti, testimonianze, si prefigge di ricostruire il passato di una certa civiltà. E quanto più questa è lontana dal presente, tanto più si ricorre all’apporto di altre scienze, quali l’archeologia, la paleontologia, la geologia, l’etnologia ecc. Al contrario, ai primordi della civiltà, il tempo mitico è sentito più del tempo storico, che acquista significato solo se si trasforma in mito. Nelle civiltà dell’Estremo Oriente, tempo e storia sono considerati illusori e la conoscenza autentica, da cui scaturisce la salvezza, avviene proprio in virtù di questa consapevolezza. Per il mondo greco la storia è ricerca, conoscenza, ma non le è mai stato attribuito un significato universale, una visione globale, una benché minima trascendenza. Per lo stesso Erodoto, considerato il primo storico, fare storia significa innanzitutto salvare la memoria dall’inesorabile erosione del tempo, cercare nel passato esempi edificanti e lezioni morali, ridare gloria a quanti con le loro azioni se la sono meritati. Il senso della storia è un’invenzione tutta ebraica. Per la prima volta si concepisce che nella storia avviene l’incontro tra umano e divino che mette fine al concetto deterministico della natura e dell’universo, dando vita alla dialettica tra le sfide lanciate dal divino e i tentativi di risposta dell’uomo. Il senso della storia nell’ebraismo sta proprio in questa interpretazione rivoluzionaria del divino. La storia si definisce nella dialettica permanente tra la volontà divina di un creatore onnipotente e il libero arbitrio dell’uomo, tra l’obbedienza e la rivolta. Il tempo mitico dell’Eden finisce con il “peccato” di Adamo ed Eva che scelgono di entrare nella storia, portando con sé però anche Dio. Da quel momento, il passato non è più collocato in un tempo mitico, ma si innesta in quello storico. Così Mosè può annunciare al popolo l’imminente liberazione dalla schiavitù dall’Egitto, non in nome del Dio creatore del cielo e della terra, ma in nome del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, uomini in carne e ossa, che la Bibbia colloca in contesti geografici precisi, di cui definisce con precisione la genealogia. E ancora, il primo comandamento, nel suo riferimento al Dio unico, lo indica come «Colui che ti ha fatto uscire dall’Egitto». Quindi Israele comprende chi è Dio da quello che ha fatto nella storia.
Funzione dello Zakhòr
Nel libro di Giosuè3 si parla dell’ingiunzione rivolta ai capi tribù di porre delle pietre per ricordare il passaggio del fiume Giordano all’entrata nella Terra Promessa. Ma poiché la memoria ebraica si esprime nel tempo piuttosto che nello spazio, queste pietre hanno lo scopo di sollecitare le domande dei figli ai padri e di sollecitare questi a trasmettere loro il ricordo di quell’evento, attraverso il racconto. E, dato che la storia non si ripete, le sue varie fasi non potranno essere rivissute se non attraverso il racconto di generazione in generazione, al punto che ognuno dovrà sentirsi come se vi avesse partecipato. Solo da questa continua trasmissione può nascere una memoria vitale, condivisa, una memoria vissuta sempre come presente. Il racc onto dell’uscita dall’Egitto La cena pasquale (Pésach è il nome ebraico della festa pasquale, la sua radice PaSaCH significa “saltare”) segue un rituale ben preciso chiamato Séder (ordine), durante il quale si legge un libro, la Haggadà, che non a caso si traduce con “racconto”, in cui si ripercorre la “storia” del popolo ebraico dal momento in cui Abramo abbandona la sua terra natale in Mesopotamia per andare «verso la terra che ti mostrerò» (Genesi, 12, 1). Durante la cena pasquale che ricorda l’uscita dall’Egitto del popolo ebraico, si recita sempre questo passo: «In ogni generazione ognuno deve considerare come se fosse lui stesso uscito dall’Egitto», a significare che ognuno deve rivivere in prima persona quell’evento, riaffermando così il legame tra l’individuale e il collettivo. È interessante notare che la Haggadà sceglie per raccontare la storia del popolo ebraico, da Abramo all’uscita dall’Egitto, un passo del Deuteronomio (26, 6-10) in cui gli avvenimenti sono narrati da «colui che porta le primizie al Tempio», da una persona cioè che non ha partecipato direttamente agli eventi. L’uscita dall’Egitto rappresenta il momento fondante della nascita della storia degli ebrei come popolo e il suo ricordo è il fondamento della loro fede e della loro esistenza ( Quattro sono i ricordi che l’ebreo deve conservare).
Memoria e oblio
Ma la memoria è anche selettiva. Non si può ricordare tutto. Anzi, la conoscenza avviene anche attraverso un processo di reminiscenza di ciò che si è dimenticato. Lo storico Yerushalmi porta l’esempio di due patologie simili nella loro opposizione. Se la perdita della memoria è grave, lo è altrettanto un eccesso di memoria, per cui non avviene mai la sedimentazione di ricordi precedenti, ma nella mente del malato affiorano tutti contemporaneamente, provocando uno stato confusionale. Ora, il divieto di dimenticare, nella tradizione ebraica, riguarda tutto quanto può interrompere quella trasmissione che assicura la sopravvivenza identitaria, in sostanza, l’etica e la legge. Un esempio: del potente re di Giuda, Manasse, la Torà si limita a dire «Fece ciò che è male agli occhi del Signore». Nulla di più. Ciò che conta è non dimenticare come si è svolto il passato. L’unico caso in cui è prescritto l’obbligo di cancellare un ricordo si riferisce ad Amalèk.
Lo Zakhòr e il Giorno della Memoria
Nella società ebraica secolarizzata dei nostri giorni si è persa questa nozione tradizionale di memoria.8 Questo vale soprattutto per la Shoah, che ha costituito una cesura delle sue forme originarie, di cui fa parte anche il valore vitale dell’oblio. Se fino ad allora, ogni evento, ogni catastrofe successivi al racconto biblico venivano interpretati in base a quel modello che vedeva comunque la presenza divina, con Auschwitz si è imposto il principio che nessun oblio è consentito. E del dovere di memoria si sono fatti carico i sopravvissuti, anche se a volte questa memoria è muta, per l’impossibilità a tradursi in linguaggio, a causa degli orrori che hanno ucciso, come dice Elie Wiesel,la parola.
Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò quei piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto il cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto. Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai. Elie Wisel, La notte
La differenza rispetto al passato è in quella assenza di Dio, sentita da quelle vittime cresciute nel solco della tradizione come lo scandalo maggiore, e nella nascita della figura del sopravvissuto-testimone, solo depositario di quella memoria, laddove la tradizione ebraica ha insegnato che ognuno deve farsi testimone tra passato e presente, per non interrompere la trasmissione di generazione in generazione sui cui si fonda l’identità ebraica. Oggi viviamo paradossalmente in un’epoca in cui si dà grande importanza alla memoria. Da quando è stato istituito il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah, altre giornate sono state stabilite per ricordare avvenimenti che hanno sconvolto la storia del XX secolo, creando quella «mistica della memoria», come la definisce lo storico Georges Bensoussan, che rischia di portare all’esatto contrario dello scopo che si prefigge, cioè a un’amnesia collettiva. Proprio per le forme spettacolari che ha assunto, questa memoria tende ad avvolgere i crimini compiuti di un’aura arcaica e ancestrale, isolandoli dal loro contesto storico reale, facendo così dimenticare che furono il prodotto più violento della nostra modernità. Tuttavia, un fatto inaspettato sembra interpellare la coscienza ebraica contemporanea laicizzata e reinserire il dovere di memoria della tragedia recente nel solco della tradizione. Il 27 gennaio 1945, giorno in cui Auschwitz fu liberato dall’Armata Rossa, era un sabato. Dai tempi del ritorno dall’esilio babilonese nella Terra di Israele, nel VI secolo E.V., il sabato avviene la lettura pubblica della Torà, il cui testo è suddiviso in un numero di sezioni (parashòt) tali da coprire il ciclo di un anno. Ebbene, quel sabato, il brano in questione era quello dell’uscita dall’Egitto e del ricordo di ciò che fece Amalèk. Che significato dare a questa che sembra essere una coincidenza? Nel momento della massima sofferenza, quell’episodio archetipico, con il suo messaggio di vita e di liberazione, ma anche con il suo monito a non dimenticare chi si è reso responsabile di tanto male, indica come la memoria di quel tragico evento non debba esaurirsi nella sola celebrazione, ma penetrare nell’intimo e nell’anima di ognuno di noi. Zakhòr non è forse un imperativo di seconda persona?
CORRIERE della SERA - Antonio Carioti : " Online la lista degli ebrei finiti nei lager "
Tratto dai miei Amici di Informazione Corretta-giuseppe casarini
giuseppe casarini
|  |  |  | |  
|
|